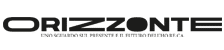Rosa, rosae, rosatum. Il vino tra le rose (e le viole)
Da rosa deriva l’aggettivo rosatum che, sottinteso vinum, letteralmente vale vino alle rose.

Chi studia latino, è noto, incomincia con rosa, rosae, etc. Da rosa deriva l’aggettivo rosatum che, sottinteso vinum, letteralmente vale vino alle rose. Ne conserviamo la ricetta dettagliata nel De re coquinaria di Apicio, qui compendiata: «Il vino alle rose (rosatum) lo farai così: cogli molti petali di rose, togli la parte bianca e mettili a bagno nel vino per sette giorni. Ripeti tre volte l’operazione sostituendo i petali con altri freschi e alla fine toglili e filtra il vino; quando vorrai berlo, aggiungi del miele. Allo stesso modo potrai fare anche il vino alle viole (violacium), sempre da condire con miele».
Come si vede, si tratta di un vino profumato, come era prassi per una vasta categoria di bevande a base di vino e aromi vari. Ma nel caso del rosatum e del violacium, vediamo che si aggiunge anche del miele per ottenere una bevanda che rientra tra quei vini chiamati dulcia (dolci), adatti anche alle donne, in genere escluse dall’uso del vino vero.
Più in generale, questi vini addolciti (anche col mosto cotto, oltre che col miele) e profumati o speziati venivano serviti, insieme a stuzzichini vari, come aperitivo nella prima parte di un convito.
A proposito di rose e di conviti, come non ricordare quello celebre in cui l’imperatore Eliogabalo, noto per i suoi lussi sfrenati, aveva fatto costruire un controsoffitto nella sala da pranzo e vi aveva nascosto una grande quantità di petali che aveva fatto poi cadere sugli ospiti (soffocandone incidentalmente alcuni)? Lo stesso imperatore è ricordato perché modificò a suo gusto proprio la ricetta del vinum rosatum, aggiungendoci il sentore resinoso del pino.
Cosa hanno a che vedere questi antichi vini rosati col rosato moderno? Probabilmente nulla, se non il nome che li accomuna. La ricetta non prescrive il colore ed è probabile che il vino da rendere rosatum o violacium potesse essere uno qualsiasi, anche se ovviamente una tinta scura avrebbe celato meglio l’alterazione dovuta all’aggiunta dei petali o addirittura delle pigne pestate e poi del miele. Si poteva persino fare un vino rosato senza rose, usando foglie di cedro e di palma: evidentemente non era il colore a ispirare il nome, ma il sentore floreale aggiunto.
Ovviamente questo non significa che gli antichi ignorassero il rosato come lo intendiamo noi, cioè un vino prodotto con uve rosse vinificate dopo breve macerazione, oppure con una miscela di uve bianche e rosse. Ma un tale genere di vino non suggeriva il nome della rosa (e si sarebbe chiamato roseum, piuttosto che rosatum), bensì quello di un vino rosso chiaro, ossia schiarito, scolorato, chiarificato, a volte anche artificialmente dopo la fermentazione, come ci ricorda sempre il nostro Apicio, che consiglia di decolorare il vino nero (atrum) mescolando farina di fave oppure albume d’uovo o, ancora, la cenere di vitalba (vitis alba, vite bianca). Proprio questa idea di clarare, cioè rendere clarum il vino, ha dato origine, nel Medioevo, al termine (vinum) claratum, da cui prendono il nome quei claret, chiaretti, a lungo considerati più consoni alle persone altolocate, dal palato e dalla costituzione delicata, aliene da quei lavori volgari e pesanti che meglio si adattavano al consumo del vino rosso.
Insomma, il vino (rosso) chiaro, antenato del nostro rosato, è stato per secoli considerato superiore a quello più sanguigno, oggi tanto in voga ma, tutto sommato, di recente nobiltà.