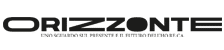«Il pinolo ha un enorme potere di riscaldare il corpo. Apporta benefici alle persone che soffrono di tremori e asma. Aumenta lo sperma».
Questa lapidaria definizione delle proprietà del pinolo si trova in uno dei più antichi ricettari in lingua araba, quello di Ibn Sayyar, noto in seguito semplicemente come al Warraq (lo scrittore-editore). Siamo nella Baghdad del X secolo, ma il libro riprende ricette anche di qualche secolo più antiche. Come avverrà in seguito nell’Occidente cristiano, i ricettari contenevano spesso raccomandazioni dietetiche basate sulle caratteristiche umorali che la scienza medica classica, passata anche a quella araba, assegnavano agli alimenti. La nota sul potere riscaldante del pinolo, rientra infatti in quell’antico sistema di pensiero che classificava esseri umani e cibi secondo gli opposti caldo-freddo e umido-secco e cercava di mantenere in equilibrio tali qualità. Le proprietà balsamiche e seminali del pinolo fanno anch’esse parte di un immaginario antico che, tra l’altro, aveva caricato il pino di complessi valori simbolici e religiosi, oltre che medico-dietetici, formatisi intorno al culto di Cibele, la Grande Madre importata a Roma dall’anatolica Frigia. La pigna gravida di semi era un trasparente simbolo evocativo dell’inesauribile potere generativo e rigenerativo della Terra che contiene e sostiene l’uomo nell’universo. È in questo scenario simbolico che si spiega la grande pigna di bronzo perforata per il getto d’acqua di una fontana monumentale nell’antica Roma, quasi certamente legata a uno dei luoghi di culto dedicati alle divinità orientali venerate nel Campo Marzio. Tornata alla luce nel Medioevo, la scultura venne poi sistemata ai Musei Vaticani, in capo alla scala progettata da Michelangelo nel cortile ancora oggi detto della Pigna, o del Pignone.
Mangiare pinoli è dunque stato per secoli non solo ingerire i gustosi frutti del pino domestico, ma anche, più o meno consapevolmente, assumere un medicamento e richiamare alla mente simboli e storie di lontanissime origini. E non ci pare un caso che il ricettario più famoso dell’antichità, quello di Apicio, abbia oltre cinquanta ricette che contemplano l’uso di nuclei pinei per comporre salse, condimenti, intingoli e farciture varie. Nel 1852, Gianbattista Baseggio traduceva i nuclei pinei di Apicio con pinocchi nella sua volgarizzazione (traduzione in italiano) di Apicio, con tanto di testo latino a fronte e dotto commentario. Pinocchio era infatti altro termine a quel tempo molto in uso per indicare i pinoli. E gli appassionati amanti della favola del fiorentino Collodi (prima edizione 1853) sanno bene che sul nome di Pinocchio sono state fatte numerose speculazioni, anche sul presunto valore simbolico del pino e del pinolo che, col passare del tempo, si è andato caricando di allusioni iniziatiche e massoniche. Speculazioni interpretative a parte, è fuori da ogni dubbio che nel mondo di Collodi i pinocchi erano i pinoli, in quell’epoca vanto della selvicoltura toscana che ne era tra le maggiori produttrici al mondo. Le incantevoli pinete della costa toscana non sono infatti una primigenia bellezza naturale, ma il risultato della plurisecolare opera dell’uomo che ha seminato e allevato generazioni di pini domestici per presidiare il retroterra agricolo e deliziare il mondo con milioni di pinoli. Tra il Pignone di Roma e il paesaggio toscano potremmo insomma trovare il filo che tiene il Pinolo più famoso del modo. Ma forse sarebbe solo una suggestione, poiché tutti sappiamo che Pinocchio è un incredibile burattino senza fili…