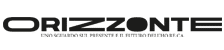“Se abbiamo acqua e polenta possiamo contendere a Giove stesso la palma della felicità”
Sogno di abbondanza per alcuni, emblema di frugalità per altri

Per i poveri e gli affamati la polenta ha rappresentato a lungo un sogno di abbondanza: proprio con questa accezione entra nell’immaginario del Paese della Cuccagna, dove la vita delle persone scorre spensierata tra mangiate e divertimento. È il commediografo greco Ferecrate (V sec. a.C.) ne I minatori, a offrire la prima rappresentazione letteraria di questo luogo: «Fiumi di farinata e brodetto nero ribollendo scorrevano colmi tra sponde strette, con bocconi di pane già preparati e pezzetti di galletta».
All’inizio dell’Asino d’oro ovvero Le metamorfosi di Apuleio, il protagonista incontra il primo di una serie di compagni di viaggio che gli confessa come abbia rischiato di rimanerci secco ingozzandosi di polenta: «L’altra sera, per esempio, mentre cercavo di mandar giù un boccone troppo grosso di polenta incaciata (si faceva a chi ne mangia di più) ecco che quella roba molle e glutinosa mi si attacca in gola e mi blocca il respiro, che a momenti soffoco».
Nel Rinascimento, la curiosità del più celebre commentatore di Apuleio, ovvero il bolognese Filippo Beroaldo il Vecchio (1453-1505), sarà stimolata proprio dalla polenta incaciata. Anche il frate carmelitano Battista Spagnoli Mantovano (1447-1516) – conosciuto con l’appellativo di Virgilio cristiano – nella sesta delle sue ecloghe (componimenti pastorali) inserisce un’accesa discussione tra due personaggi, Folaga e Cornacchia, sul periodo di preparazione della polenta. Un secolo più tardi, Bernardino Baldi (1553-1617) descrive, in Celeo, o l’orto, la realizzazione di una polenta di bianca farina (probabilmente di miglio) che il protagonista ricopre di «trito cacio» e di burro, che ne penetra «tutto il penetrabil corpo». Questo espressionismo si ritrova anche nell’opera di un altro frate, Merlin Cocai, più noto come Teofilo Folengo (1491-1544), che rappresenta la più significativa espressione rinascimentale del genere carnevalesco. Nel proemio, infatti, la polenta compare accompagnata agli gnocchi nell’invocare l’aiuto delle Muse Mangione: «vengano qui a imboccare/il loro caro poeta di gnocchi, e mi diano cinque o anche otto tegame/di polenta fumante». Persino Giacomo Leopardi, all’inizio della sua Guerra dei topi e delle rane del 1826, fa vantare il topo Rubabriciole di riuscire a mangiare sempre «a sbaffo» i più prelibati cibi degli uomini; i quali, però, se non degustati come meriterebbero, servono solo a «riempire i budelli»: «Or la polenta ingrassami i budell / Or fette di prosciutto, or fegatelli.»
Dal lato opposto, un altro filone, più aristocratico e talvolta un po’ ascetico, identifica la polenta come pasto frugale per eccellenza contrapposto agli sfarzi culinari troppo spesso ostentati. È così che la intendono scrittori latini del I secolo d.C. come Persio, che vede le contaminazioni dei costumi culinari come segno di decadenza «È così: da quando la sapienza [forestiera] è arrivata in Roma con i datteri e il pepe e questa nostrale [è caduta in disprezzo] i nostri falciatori hanno imparato a guastare la polenta con il burro». Allo stesso modo Giovenale sfida Persico a vedere se c’è differenza tra la vita frugale che proclama e quella che conduce utilizzando la polenta come esempio. Marziale, dal canto suo, invita infine l’amico Toranio a far penitenza a casa sua con una cenetta davvero sobria ma in cui si sentirà completamente a suo agio: «Ti sarà presentato, su uno scuro piatto, un verde cavolo colto or ora nel freddo orto, che dovrai prendere scottandoti le dita, una salsiccia adagiata sopra una bianca farinata [polenta], delle bianche fave con rosso lardo».
Anche Seneca, in una delle sue più note lettere a Lucilio, esalta, attraverso la polenta, un’alimentazione semplice e contenuta; lo ricorda un suo grande ammiratore, Francesco Petrarca (1304-1374), nella sua lettera-testamento diretta a Lombardo da Serico in cui elogia la scelta dell’amico di vivere lontano dalle mollezze degli uomini, accontentandosi di alimenti semplici: «Quando uno del gregge di coloro che sono vergognosamente servi del loro ventre – la parte più ignobile del corpo – ti chiese ridendo cosa tu mangiassi, tu rispondesti: “Pane e polenta”. E quando poi ti chiese cosa bevessi, gli mostrasti il pozzo […] “Non sono cose deliziose in se medesime l’acqua, la polenta ed il pane d’orzo, ma è vera felicità il saper trarre piacere da ciò che nessuno può toglierti” [Seneca, Ad Luc. 18, 10].» Qualche tempo dopo, a Venezia, l’Arlecchino di Carlo Goldoni, ne La donna di garbo, è attirato irresistibilmente dal profumo della polenta fumante appena versata sul tagliere di legno. Ne Il servitore di due padroni, invece, spetta al bergamasco Truffaldino riconoscere e lodarne l’odore. Amore incondizionato per la polenta dimostra, sul finire del Settecento, anche il letterato Ludovico Pastò (1744-1806) che, ne I due brindisi, le dedica un’ode: «La me piase dura e tenera,/In fersora e sula grela,/in pastizzo, in la paela;/Coi sponzioli, coi fongheti,/col porselo, coi oseleti./Cole tenche, coi bisati,/co le anguele per i gati;/e po’ insoma in tuti i modi/la polenta xe ‘l mio godi».
Insomma, basta avere la possibilità di condirla a dovere, che la polenta diviene buona anche per le tavole dei ricchi, come dirà Giovanni Pascoli (1855- 1912) nel finale del suo poemetto Per casa. Allo stesso modo, ne Il Desinare, il poeta ne racconta la certosina preparazione: «Ubbidì Rosa al subito comando./Sotto il paiolo aggiunse legna, il sale/gettò nell’acqua che fremé ronzando.//Stacciò: lo staccio, come avesse l’ale,/frullò tra le sue mani, e la farina/gialla com’oro nevicava uguale.//Ne sparse un po’ nell’acqua, ove una fina/tela si stese. Il bollor ruppe fioco./Ella ne sparse un’altra brancatina.//E poi spentala tutta a poco a poco,/mestò. Senza bisogno di garzone,/inginocchiata nel chiaror del fuoco,//mestò, rumò, poi schiaffeggiò il pastone,/fin che fu cotto; e lo staccò bel bello, l’ammucchiò nel paiolo, col cannone/di pioppo; e lo sbacchiò sopra il tarvello.» La madre, nel frattempo, aveva già preparato gli ingredienti per condirla: un trito di radicchio e di altre erbe aromatiche, da friggere nell’olio insaporito con l’aglio.
Quando l’ex cappuccino Costantino Longaretti regala alcuni tordi a Carlo Porta (1775-1821), il poeta li serve per cena ad alcuni amici, configurando la famosa ricetta di polenta e osei: «Quanto ai tordi, quanto ai merli/eran pingui, freschi e sani/che una gioia era il vederli,/il palparli con le mani./Ma la gioia la più intensa/quella che fu dei convitati,/allorquando sulla mensa/caldi caldi fur portati,/Volti in candide indumenta,/con lardosa maestà,/sedean sopra una polenta/come turchi sul sofà.» (epistola 53 del Canzoniere).
Altra lode della polenta, che ne immortala gli stadi di preparazione, è contenuta nella commedia mai rappresentata Basi e bote (1881) del padovano Arrigo Boito (1842-1918), da cui si può imparare «l’arte di menar bene la polenta e de metterghe el pocio»; ma la comparsa più celebre nella letteratura italiana moderna è forse nel VI capitolo dei Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Si tratta della «polenta bigia, di gran saraceno» (o fagopiro, che nel Seicento, tra i cereali, era uno degli ultimi arrivati) in cui i lettori del romanzo si imbattono con Renzo a casa di Tonio: «[Renzo] andò addirittura, secondo che aveva disegnato, alla casetta d’un certo Tonio, ch’era lì poco distante; e lo trovò in cucina, che, con un ginocchio sullo scalino del focolare, e tenendo, con una mano, l’orlo d’un paiolo, messo sulle ceneri calde, dimenava, col matterello ricurvo, una piccola polenta bigia, di gran saraceno. […] Mentre Renzo barattava i saluti con la famiglia, Tonio scodellò la polenta sulla tafferìa di faggio, che stava apparecchiata a riceverla: e parve una piccola luna, in un gran cerchio di vapori.»
Qualche tempo dopo Umberto Saba (1883-1957) si concentra invece sull’aspetto estetico della polenta. In Cucina economica, uno dei componimenti della raccolta Il Piccolo Berto, il poeta esalta quel colore giallo paglierino da cui scaturiscono rivelazioni portatrici di salvezza.
Per Andrea Zanzotto (1921-2011), invece, la polenta diventa il ponte tra anima e memoria: «Io vi voglio ancora, mie mattine, voglio vivere, e nelle vostre ombre incristallite dal profumo della notte mi siedo tra i cespugli e intingo nello zucchero la fredda polenta, gelatinosa come torta di crema; e il mio cuore palpita più che per qualunque amore mentre essa e lo zucchero si fondono nella mia bocca e giù nel petto con l’anima dolente. O polenta e cannella. […] Parlami ancora di te, polenta, dimmi come mi proteggevi mentre per meglio assimilarti ti facevo a pallottole e ti stringevo forte nel pugno, e tu uscivi spiaccicata tra le dita, donde la mia lingua ti coglieva! […]».
Anche nel racconto Polenta e formaio zè bòn! di Mario Rigoni Stern (1921-2008) la polenta apre una finestra sul passato. Luisa, che vuole conoscere i luoghi dove il nonno ha fatto il partigiano mezzo secolo prima, si reca sull’altopiano di Asiago, dove conosce le persone che con lui avevano combattuto durante la Resistenza. Attorno a una tavola dove troneggia una polenta da accompagnare con coniglio e formaggio, si rievocano sensazioni e ricordi.