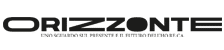Il Dio dei piccoli luoghi
Che cosa significa, dunque, osservare un luogo? Fino a quale distanza può spingersi l’occhio del fotografo?

Erano dèi sconosciuti, spesso dee, ninfe e poi fate. Erano divinità minori, dai poteri confinati al loro mondo: una fonte, una cima, l’ombra di un albero antico.
I latini avevano un nome per la loro categoria di adorazione, quasi familiare: genius loci. Nella nostra epoca, quella definizione si è conservata. Abbandonando il corpo etereo degli spiriti è diventata una qualità speciale che appartiene a un singolo spazio del nostro mondo e solo a quello, irripetibile e unico.
I fotografi hanno rubato ai pittori di paesaggio il presunto talento di riconoscere il genius loci. La fotografia, che sa solo raccogliere un qui e ora, sembrerebbe dotata per natura di questa capacità. Ovvero, di questa limitatezza. Che è una felice condanna.

C’è sicuramente un motivo se i fotografi, che non disdegnano le vedute ampie, i panorami a tutto orizzonte che hanno sempre un sapore di eternità, preferiscono i dettagli, gli angoli modesti e nascosti delle cose. Scrisse Gaston Bachelard: «Ogni oggetto investito di spazio intimo diventa centro di tutto lo spazio». Quando Talbot mise assieme il primo fotolibro della storia, che è anche il primo trattato di filosofia della fotografia, scelse molte di queste immagini senza importanza, senza gloria e senza storia. Una su tutte, The Open Door, con quella scopa che sbarra il passo a una soglia oltre la quale c’è un’oscurità che attira e impaurisce. In quella fotografia, tutto esiste in una distanza tangibile, abitabile, tutto sembra a portata di mano in uno spazio certo e finito. I fotografi non hanno mai mancato di celebrare questi piccoli mondi, soffermandosi a volte sui dettagli più umili e semplici.
C’è chi raccomanda di fotografare questi luoghi, questi posti nascosti, con una certa rapidità di esecuzione, per evitare che, nella relativa lentezza della procedura, il pensiero prenda il sopravvento sull’occhio.
Fotografare i piccoli luoghi, quelli insignificanti, non sarebbe insomma solo una ricerca dell’intimità, una fuga dalla retorica, ma una specie di pratica mediale, una messa in discussione del funzionamento stesso della fotografia, una ricerca del suo limite.
Che cosa significa, dunque, osservare un luogo? Fino a quale distanza può spingersi l’occhio del fotografo? Potrei dire, in estrema sintesi, che osservare un luogo significa liberare lo sguardo dalla “previsualizzazione”, dai propri stereotipi culturali, dalle aspettative estetiche e dalle tradizioni iconografiche.
Se osserviamo con la giusta attenzione, saremo in grado di cogliere qualcosa che avevamo fino ad allora visto solo con la coda dell’occhio.
Foto di Federico Minelli